Epidemia e trappole linguistiche
di Patrizio Paolinelli
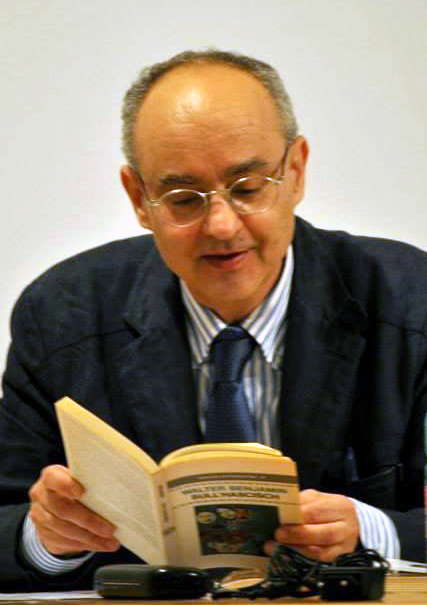
Improvvisamente numerose interdizioni hanno sconvolto le consuete forme d’interazione sociale degli italiani: l’obbligo alla quarantena nella prima fase dell’epidemia da coronavirus, le stringenti regole di condotta da tenere nella fase successiva, i controlli delle forze dell’ordine per verificare il rispetto delle misure anticontagio. Il nuovo ordine di convivenza si è strutturato intorno alla condivisione di nuovi anglicismi e al concetto di distanza.
<<== Prof. Patrizio Paolinelli
Fatta eccezione della sigla Covid-19 gli anglicismi di maggior successo sono stati lockdown e smart working: il primo una novità, il secondo già noto e rilanciato in grande stile con la pandemia. Negli Stati Uniti lockdown ha due significati: isolamento dei detenuti nella propria cella; misure di sicurezza che vietano l’entrata e l’uscita da una determinata area. Nonostante esprima due concetti differenti tale termine è stato utilizzato dall’Oms all’inizio dell’epidemia quando le autorità cinesi hanno isolato Wuhan. E la stampa italiana ha seguito a ruota senza porsi alcun problema. Sempre il nostro sistema d’informazione ha introdotto il termine droplets (goccioline salivari potenziali veicoli di infezione), cluster (presenza di due o più casi affetti da coronavirus in aree al di fuori dei focolai) e il concetto di helipcoter money (trasferimento di denaro nelle tasche dei cittadini), ma per il momento non sembrano aver avuto grande presa sull’opinione pubblica. E comunque, sia i media sia diversi esponenti politici insistono.
Il fronte anglofono però presenta almeno un paio di importanti defezioni. Nei documenti ufficiali il governo ha privilegiato la locuzione misure di contenimento al posto di lockdown e al posto di smart working il già collaudato lavoro agile, presente nella nostra legislazione dal 2017. Anche il Ministero della Salute ha usato misure di contenimento e optato per goccioline anziché utilizzare il forestierismo droplets.
Durante questi primi mesi di pandemia si è dunque assistito a una partita tra la lingua italiana e quella inglese. Chi ha vinto? La lingua inglese. Anche perché le nostre istituzioni hanno giocato con poca convinzione. Forse si sentivano già battute o, peggio ancora, non si sono accorte di giocare una partita. In ogni caso oggi sono i media a decidere quali parole includere o escludere dal discorso pubblico. Una rete comunque l’abbiamo più o meno consapevolmente segnata: la nostra “distribuzione a pioggia” non è stata spodestata da helipcoter money.
È difficile resistere alla capacità di attrazione degli anglicismi: l’inglese è la lingua della nazione-guida dell’Occidente, del potere economico e dell’alta tecnologia. Il suo prestigio permette agli italiani che lo usano nel parlare quotidiano di sentirsi appartenenti a una categoria privilegiata e al passo coi tempi. Se si guarda alla storia non siamo dinanzi a un fenomeno nuovo e oggi gran parte dei linguisti sostengono che l’invasione di termini inglesi non costituisce un pericolo per l’integrità dell’italiano. Qualche dubbio però sorge quando l’introduzione di parole straniere nasconde intenzioni egemoniche sulla lingua d’arrivo, genera sudditanza culturale, veicola valori, modi d’essere e di vivere; in una parola, un’ideologia. È esattamente quanto accade con l’inglese. L’affermazione del lemma lockdown e dell’espressione smart working conferma l’efficacia della strategia statunitense di americanizzare il mondo. Strategia che trova un terreno particolarmente fertile in culture nazionali deboli come quella italiana. Paese formatosi da poco più di 150 anni, con un’unità linguistica completata appena nel secondo dopoguerra, un’identità nazionale fragile e che de facto è un protettorato USA.
Paesi come la Francia, che non soffrono di una sovranità limitata come la nostra, alla parola lockdown hanno preferito confinement. D’altra parte i francesi usano ordinateur al posto di computer, souris al posto di mouse, Mél (messagerie électronique) al posto di e-mail e difendono a spada tratta la loro cultura dai processi di americanizzazione che penetrano attraverso Hollywood, le serie televisive made in Usa, la musica pop e così via. Il motivo di tanta resistenza è semplice: non si può essere sicuri della propria indipendenza (politica, economica, culturale) quando si è alleati con una nazione immensamente più forte. Perché dovrebbe trattarti da pari a pari?
Noi che abbiamo l’indipendenza concessa a un vassallo non possiamo opporre una resistenza simile a quella dei francesi. La cosa dà ulteriormente da pensare se si considera il progressivo impoverimento della nostra lingua. Fenomeno particolarmente evidente nelle giovani generazioni. È noto che mediamente le matricole universitarie si esprimono male e fanno errori da terza elementare quando provano a scrivere qualcosa. Più la nostra lingua si impoverisce più gli anglicismi s’introducono nel vocabolario italiano. Certo, punto di forza dell’inglese è che corrisponde all’idioma dei commerci, del marketing e della globalizzazione tant’è che in Cina è inserito nei programmi della scuola primaria. In teoria anche da noi le lingue straniere si insegnano dalle elementari. In teoria, perché in pratica i nostri studenti si diplomano alle superiori senza averne una conoscenza adeguata. Probabilmente se nelle scuole italiane si studiasse bene l’inglese saremmo soggetti meno passivi dinanzi alla sua penetrazione. Ma dato che non si impara bene neanche l’italiano la nostra identità culturale ne risulta ancor più incerta. Un problema che la politica dovrebbe prendere in seria considerazione. Non è una questione di nazionalismo: salvaguardare una lingua, meglio ancora, l’identità culturale di un popolo è una ricchezza per tutto il genere umano.
Per quanto riguarda la distanza o il distanziamento sociale si tratta di calchi dall’inglese social distance e social distancing. Pertanto sarebbe stato inutile rinunciare all’italiano e tuttavia la stampa li ha usati e li usa con una certa frequenza. Anche in questo caso c’è chi non si è allineato. Ancora una volta il Ministero della Salute, che ha preferito adottare il concetto di distanza interpersonale e sul Web si sono registrate diverse posizioni favorevoli a distanza fisica. Tuttavia in alcune occasioni il nostro capo del governo e lo stesso ministro della salute hanno usato l’espressione distanziamento sociale. Al contrario, il primo ministro francese, Édouard Philippe, l’ha definita “ripugnante”.
Il concetto di distanza sociale utilizzato in questi mesi non è stato tratto dalla riflessione sociologica, che sull’argomento vanta una lunga tradizione, ma da una classificazione del grado di prossimità fisica elaborata negli anni ’60 del secolo scorso dall’antropologo Edward Hall. Secondo Hall esistono quattro zone differenti di gestione dello spazio in cui si articolano altrettante forme di comunicazione. La prima è la distanza intima (dal contatto fino a 45 centimetri), riservata ai rapporti molto stretti (marito-moglie, genitori-figli e così via). La seconda è la distanza personale (da 45 centimetri a 1,2 metri), che si tiene di solito con gli amici e i conoscenti. La terza è la distanza sociale (da 1,2 a 3,5 metri); in genere si tiene in occasioni formali, tra sconosciuti, tra individui che appartengono a differenti classi sociali. Infine, abbiamo la distanza pubblica (da 3,5 metri in su) come quella tenuta da un oratore rispetto all’auditorio.
Bene, chiariti i termini della questione ecco due incongruenze che presenta la categoria distanza sociale applicata alla definizione delle misure anti-contagio. Prima incongruenza, nel normale andamento della vita quotidiana la distanza sociale non è imposta per decreto né prevede sanzioni se con l’accordo tra le parti da sociale passa a personale. Seconda incongruenza: nelle interazioni pre-pandemiche la distanza sociale costituisce un potenziale comunicativo: può infatti trasformarsi in distanza intima come nel caso di due sconosciuti che si incontrano, si conoscono e poi avviano una relazione amorosa. Se con la pandemia non si può dire che tale potenziale sia del tutto annullato sicuramente è notevolmente ridotto. Viceversa, nella prospettiva di Hall la distanza sociale costituisce un fattore dinamico della comunicazione attraverso i giochi di manipolazione dello spazio.
L’insieme di questi motivi avrebbe sconsigliato l’uso del concetto di distanza sociale in relazione alla pandemia preferendogli quello assai più calzante di distanza interpersonale o di sicurezza. Allora perché giornalisti, politici e virologi lo hanno utilizzato? Un po’ per pigrizia, un po’ per la fretta dettata dall’emergenza, ma soprattutto perché siamo tutti immersi nell’ordine del discorso economico neoliberista. Il cui gergo, il celebre aziendalese, marginalizza l’idea stessa di società. Idea che ancora non si può sopprimere del tutto e che viene surrogata nei concetti di relazione, gruppo, comunità o ingabbiata in quello di social network. Concetti invariabilmente subordinati a una visione egoistica dell’esistenza.
Questo modello di controllo ideologico del linguaggio è da tempo consolidato negli Stati Uniti, tanto che negli anni ’60 Herbert Marcuse l’aveva catalogato come “Chiusura dell’universo di discorso” e considerato una delle cause che nelle società avanzate impediscono ogni sostanziale cambiamento “inteso come mutamento qualitativo che porterebbe a stabilire istituzioni essenzialmente diverse, imprimerebbe una nuova direzione al processo produttivo e introdurrebbe nuovi modi di esistenza per l’uomo”. Associare la parola società a un evento tragico come la pandemia e all’obbligo di lontananza dagli altri significa denotarla negativamente, così come è esercizio quotidiano dell’aziendalese denotare negativamente il socialismo, lo stato sociale, la solidarietà; a cui oppone l’individualismo, la ricchezza personale, la concorrenza. Dall’attuale governo e dai partiti che si richiamano ai valori della sinistra ci saremmo aspettati maggiore consapevolezza sull’importanza delle funzioni di una lingua. Così non è stato e l’americanizzazione dell’Italia continua.
Patrizio Paolinelli, Via Po cultura, inserto del quotidiano Conquiste del Lavoro, 30 maggio 2020.






