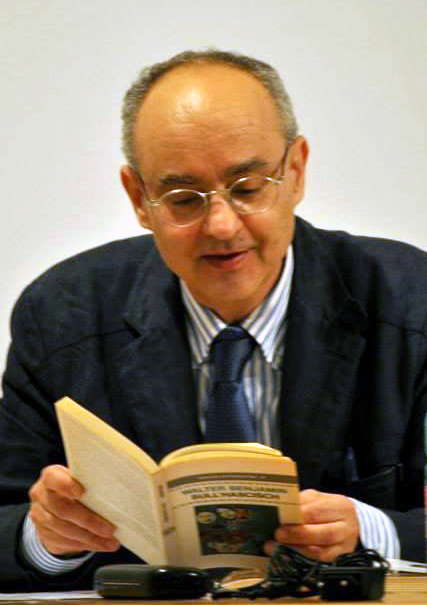John Wick, metafora estrema della nostra società
di Patrizio Paolinelli

John Wick è una saga del cinema d’azione prodotta negli USA. Un successo di botteghino cresciuto film dopo film: il primo esce nel 2014, costa 20 milioni di dollari e ne incassa 89; il secondo compare nelle sale nel 2017 (coproduzione USA, Hong Kong, Italia), costa 40 milioni e ne incassa 170; il terzo è del 2019, costa 75 milioni e ne incassa 322. Nel 2021 è prevista l’uscita del quarto capitolo della storia e nello stesso anno vedrà la luce una serie televisiva spin-off. Per non trascurare alcuna opportunità di business è in vendita il merchandising, è stato creato il fumetto e quest’estate uscirà il videogioco. Attore protagonista della trilogia è Keanu Reeves. Regista l’ex stuntman Chad Stahelski, alle sue prime prove dietro la macchina da presa.
John Wick è un leggendario killer che ha lasciato la professione per vivere con Helen, l’amore della sua vita. Dopo cinque anni la donna muore stroncata da un male incurabile. Col cuore spezzato John decide di isolarsi dal mondo per coltivare il ricordo della moglie. Ma, suo malgrado, eccolo nuovamente risucchiato nel vortice della società del crimine. La prima volta per farla pagare al figlio viziato di un gangster russo che gli ha rubato l’auto, ucciso il cucciolo di beagle (che Helen aveva disposto gli venisse recapitato dopo il suo funerale) e fatto pestare a sangue dai suoi sgherri; la seconda perché costretto a saldare un vecchio debito contratto con un capo della camorra; la terza per sfuggire a una torma di killer desiderosi di intascare una grossa taglia messa sulla sua testa dalla Gran Tavola (una sorta di consiglio di amministrazione del crimine planetario che detta le regole a cui i killer debbono attenersi e che John ha disatteso). Tre cliché del cinema d’azione: la vendetta, il passato che torna, la fuga.
Tutto da copione, verrebbe da dire. È da copione la trama scandita all’azione, il cast artistico subordinato al protagonista, il plot elementare, i dialoghi ridotti all’osso. E come da copione John non fa che prodursi quasi senza soluzione di continuità in mortali combattimenti lasciandosi alle spalle un numero incalcolabile di cadaveri. Se le formule sono trite e ritrite come ha fatto John Wick a trovare un posto tra gli dei che popolano il già affollato olimpo dei film d’azione? Cosa ha decretato il successo della saga?
È evidente che le risposte vanno cercate nell’originalità del personaggio. La cui vicenda fa esplodere in tutta la sua portata il nichilismo che da decenni percorre le vene della nostra società e sfibrato ogni legame. Niente sta in piedi nell’universo anomico di John: non ci sono certezze a cui appigliarsi, obiettivi per i quali valga la pena lottare, speranze da accarezzare, un domani da sognare; non ci sono ruoli da rispettare, istituzioni da difendere, nulla da farsi perdonare, né atti di eroismo o di altruismo da compiere. Tutto vacilla, tutto trema, tutto viene travolto dall’eruzione del vulcano nichilista: il senso di appartenenza, di responsabilità, di solidarietà, persino la struttura del sentire. L’unica maniera di abitare un mondo dove non c’è nulla è aggiungere altro nulla: quello che fa John Wick camminando nel vuoto del mondo del crimine, metafora estrema della nostra disgregata società.

Muoviamo i primi passi partendo dal corpo del protagonista. Keanu Reeves non ha la faccia da duro. Semmai quella del bravo ragazzo, bello, romantico e malinconico. La regia però riesce a sfruttare efficacemente il coté tenebroso del suo sguardo accordandolo con quello di un implacabile carnefice. Operazione riuscita perché sintonizzata con la serie di negazioni che definiscono il personaggio. La prima l’abbiamo appena individuata: John Wick è bello ma non è buono: dunque l’estetica nega l’etica.
A conferma: John non possiede il fisico di un body builder come richiesto ai protagonisti dei film d’azione. Non esibisce bicipiti esplosivi, addominali a tartaruga né è dotato delle capacità atletiche di un Van Damme: l’imbattibilità non necessita di una muscolatura portentosa. Se il canone fisico rompe con la tradizione del film d’azione l’abbigliamento vira con decisione verso il classico. La tenuta da combattimento di John Wick è un elegante abito scuro. Ma ecco una nuova sterzata. Nell’ambiente del crimine John è noto col soprannome di Baba Yaga, tradotto in italiano come Uomo Nero. Creatura leggendaria che un tempo terrorizzava i bambini e nella nostra trilogia i criminali incalliti. Purtroppo per noi non ci è dato il tempo di cullarci nelle paure infantili che subito dobbiamo aprire gli occhi e tornare nel mondo degli adulti: l’Uomo Nero veste come un ricco agente di borsa. Un agente di borsa sui generis visto che se le dà di santa ragione con altri agenti di borsa. Ma non è quello che fanno nella realtà?
Che si sparino addosso, si accoltellino, si prendano a pugni o a colpi di Kung Fu gran parte dei protagonisti degli innumerevoli combattimenti che costellano la saga indossano giacca e cravatta. Fanno eccezione gli arabi e gli asiatici per marcare la dimensione internazionale del mondo del crimine in cui opera John Wick. In coerenza col look formale John non fa nessuna concessione alla visibilità del corpo a cui ci hanno abituato i possenti petti nudi di uno Stallone, di uno Schwarzy dei tempi d’oro o più recentemente di un Dwayne Johnson, di un Vin Diesel e di tante altre star del cinema d’azione. Nella nostra trilogia ci si ammazza, sì, ma è gradito l’abito scuro: così si fa nell’alta finanza, così si fa nell’élite del crimine.
Abito e corpo di Baba Yaga-Agente di Borsa sono indistruttibili: entrambi non si sgualciscono più di tanto nonostante scontri, inseguimenti e fughe. L’abito perché ha incorporato nel tessuto una fibra antiproiettile, il corpo perché è tessuto con la materia inerte del nichilismo. John Wick non muore mai non perché è una divinità omerica ma perché è anestetizzato dalla vita. È un killer taciturno che con fredda determinazione procede alle complicate esecuzioni dei condannati che incontra sulla sua strada. I quali si difendono, si agitano, oppongono strenua resistenza esercitando il libero arbitrio di un fuoco fatuo. Si trovano già sul patibolo e la loro sorte è segnata. Per questo motivo John non deve faticare neanche un po’ per raggiungere le sue vittime. Parte all’attacco in doppio petto come se andasse a una festa. Festa in cui tutti sperano di non incontrarlo. Ma lo incontrano e gli tocca danzare la danza della morte.

Pur con la cravatta sempre a posto qualche volta John esce malconcio dalle sue esecuzioni. Ma quanto malconcio? In apparenza tanto, in realtà poco. Ferito all’addome da una coltellata un anziano medico gli applica numerosi punti di sutura e gli consiglia di riposarsi. John si mette a letto, non fa in tempo a chiudere gli occhi che eccolo impegnato in un violento scontro all’arma bianca con una terribile killer intrufolatasi in camera sua con l’intento di ucciderlo. Non solo non ci riesce, ma viene giustiziata per aver infranto la regola di non belligeranza che vige al Continental, l’esclusivo hotel per sicari dove John momentaneamente alloggia. In altri casi lo schema è ribaltato: niente può scalfire John. Neanche quando è investito da un’auto in corsa. John rotola a terra, si rialza prontamente, non ha neanche la necessità di spolverarsi l’abito e continua a combattere: la vulnerabilità è negata dall’invulnerabilità. Caratteristica che indurrebbe a pensare a un nuovo mito d’oggi. Così non è. Un mito è tale per il messaggio che trasmette e John Wick non è portatore di alcun messaggio.
Alla società del crimine non basta il gioco delle negazioni. Nella finzione scenica talvolta si scioglie nella fantasia. Per esempio, il richiamo all’incorporeo Uomo Nero permette al John in carne ed ossa un mimetismo da mantello magico. Eccolo correre vistosamente ferito per strade e metropolitane affollate lasciandosi dietro una scia di sangue: non una sola persona si gira a guardarlo. Nessuno lo vede perché non si nota ciò che siamo abituati a vedere: la violenza che ci circonda promuove alla normalità l’occhio cieco dell’indifferenza. Dunque John non ha bisogno di nascondere la sua sofferenza al mondo. È visibile solo ai suoi avversari. I quali, manco a dirlo, ingaggiano lotte furibonde con John e vengono sistematicamente sopraffatti. In altre circostanze L’Uomo Nero agisce come uno spirito della notte. Sbuca fuori all’improvviso e si prende la vita delle sue prede. Raramente lo spettatore sa come abbia fatto a sorprenderle. E anche quando lo sa le informazioni sono scarse. Di preciso sa che John è visibile e invisibile allo stesso tempo. Unione dei contrari? Dialettica incompiuta? Né l’una né l’altra. È la vita che non vive.
Anche un’epoca senza divenire genera riti. E la routine di combattimenti della nostra trilogia eleva il rito della lotta a massimo beneficio per gli occhi dello spettatore. Spettatore a cui la sceneggiatura concede qualche intervallo per non fiaccarne la resistenza ottica. Durante queste pause il pubblico può assistere a brevi scambi di battute che servono a preparare i successivi scontri. Poi la giostra della morte riprende a girare con tutto il suo carico di adrenalina. Giostra che nella trilogia di John Wick assume le forme del videogioco picchiaduro proiettato sul grande schermo. Da videogioco è l’inizio a passo di carica di ognuno dei tre film (in crescendo nel secondo e nel terzo); da videogioco è il doppiopetto salvavita di John; l’incessante susseguirsi di combattimenti in cui si vive o si muore; i gregari dei campioni di arti marziali che cadono come birilli sotto il fuoco dell’Uomo Nero e i campioni di arti marziali che lo sfidano e perdono; da videogioco è la completa assenza di suspense. Infine, da videogioco è la nostra vita quotidiana, la cui frenetica routine è fatta di traffico congestionato, urgenze, emergenze, scadenze, troppi impegni da rispettare, troppi bisogni da soddisfare, troppi conti da pagare, troppi nemici da combattere, troppe ferite da curare. E tutto questo affanno in una spaventosa solitudine interiore. La stessa di John Wick.
Un altro passo nel vuoto ci fa cadere nel sistema dei valori. Anche in questo caso vale il principio della negazione. John non lotta per imporre valori tangibili: la sete di denaro (non è mosso da un utile economico); la forza muscolare (non ha un fisico particolarmente dotato); il potere della mente (non gli occorrono grandi investigazioni per scovare le sue vittime); l’alta tecnologia (per uccidere usa pistole, fucili, coltelli, talvolta oggetti e soprattutto le mani); né deve salvare il suo amore (la moglie è morta). Neppure lotta per imporre valori intangibili: la gloria (vorrebbe starsene lontano da tutto e da tutti); la patria (la sua patria è la società del crimine, nella quale però non si riconosce più); l’onore (nel mondo di John Wick non c’è onore, tutti i legami sono provvisori, incerti, inaffidabili).

Appassiona John Wick? Certo che appassiona: per assenza di passioni. John non ha veri amici. L’unico che sembrerebbe tale e che gli salva due volte la vita muore a metà del primo capitolo. John lo ringrazia appena. E lo stesso John uccide un’amica per pagare il pegno al capo camorrista (fratello della vittima). Le tiene la mano mentre lei sta morendo dissanguata dopo essersi tagliata le vene. Un gesto di umanità? Dura un attimo: la finisce sparandole in testa. Per tutta la saga il direttore del Continental di New York sembra affezionato a John e lo sostiene in diverse occasioni. Ma alla fine del terzo capitolo non esita a prenderlo a revolverate per il proprio tornaconto.
Nessun nuovo amore si profila all’orizzonte. Le donne che lo circondano non lo inducono in tentazione e per di più sono colleghe killer o malavitose delle quali non ci si può fidare. Se lo aiutano è per calcolo e comunque alla fine lo abbandonano al suo destino. Dopo la perdita di Helen il cuore di John non ha più ragioni e se anche le avesse non lo interessano, salvo colpi di scena nel prossimo capitolo della saga. Ma se così fosse si si snaturerebbe la sua storia. Non sarebbe la prima volta che l’industria cinematografica si pente delle proprie azioni. Per restare a Keanu Reeves è accaduto con Matrix: motivo di riflessione il primo capitolo, operazione commerciale di basso profilo i due successivi. Il prossimo John Wick continuerà a camminare nel vuoto?
In un mondo che ha azzerato cause a cui immolarsi e passioni a cui dedicarsi anche le istituzioni precipitano. A iniziare dalla più importante di tutte: il denaro. Nella società criminale di John circola una moneta speciale di cui però non si comprende l’effettivo valore, nessuno si dà da fare per procurarsela, non è oggetto di contesa e nei tre film non se ne vedono altre in circolazione. A dire il vero in ogni capitolo viene messa una taglia in dollari sulla testa di John. Ma come sappiamo nessuno riesce a intascarla. Neppure l’economia è un’ancora di salvezza.
La giustizia latita meno. Ma forse sarebbe stato meglio che non fosse apparsa per nulla visto come viene ridicolizzata. Per quanto John e i suoi avversari si sparino in pubblico e si inseguano in folli corse in automobile per le strade della città la polizia non compare mai. Neanche una sirena in lontananza. Le uniche due volte che fa capolino è una parodia incarnata dall’ossequioso agente Billy. Il quale peraltro sa che John è un killer professionista. Ma non ha nulla da obiettare. Crimine e violenza sono nell’ordine delle cose.
E la famiglia? Non esiste. Tutti sono soli. Allora ci salverà la cultura? Neanche. Le matite non servono per disegnare o scrivere ma per uccidere (John è famoso per aver fatto fuori tre avversari proprio con una matita). I libri appaiono una volta in casa di John, ma in cantina. Un’altra alla New York Public Library in cui John ha nascosto all’interno di un volume oggetti necessari alla fuga. Con lo stesso libro uccide brutalmente un gigantesco killer che tentava di fargli la pelle per intascare la solita taglia (uno dei rari momenti à la Tarantino della trilogia). John rispetta le regole del mondo del crimine? No, come nessuno peraltro. Tutta la saga è una giravolta di impegni presi e non mantenuti, di regole disattese, di rapporti gerarchici che saltano. Tutti sono contro tutti, l’amico di oggi è il nemico di domani e la fiducia non ha diritto di cittadinanza nel mondo di John. Come nel nostro.
Nota finale.
Di solito i film d’azione made in USA sono un’apologia più o meno diretta del sistema sociale americano. Con John Wick l’ideologia a stelle e strisce scricchiola rumorosamente. L’aquila calva non vola più e l’intera saga non offre una sponda alle inquietudini della nostra epoca. Segno dei tempi.
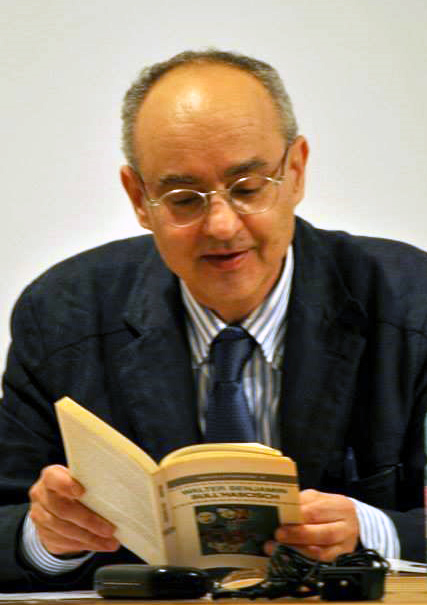
Patrizio Paolinelli, Via Po cultura, inserto del quotidiano Conquiste del Lavoro, 6 giugno 2020.