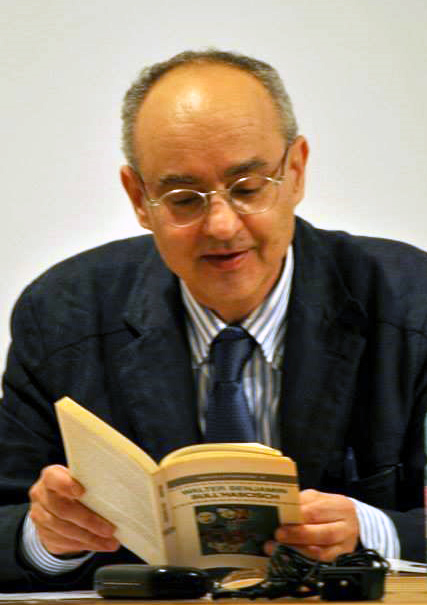Le responsabilità del potere e il potere della responsabilità
di Patrizio Paolinelli

Dinanzi al continuo susseguirsi di scandali che investono la pubblica amministrazione, il mondo politico e quello imprenditoriale si sente spesso dire che “In Italia nessuno si assume le proprie responsabilità”.
<<= Prof. Patrizio Paolinelli
In genere con questa affermazione si intendono diverse cose: 1) gli attori coinvolti nello scandalo faranno di tutto per sottrarsi alla punizione; 2) la tecnica dello scaricabarile impedirà di individuare i colpevoli; 3) dei maggiori responsabili nessuno pagherà; 4) nel nostro Paese esiste una sorta di impunità delle classi dirigenti in virtù della quale le persone coinvolte nello scandalo se la caveranno, al massimo si troverà un capro espiatorio che coinciderà quasi sempre con un pesce piccolo.
Questa elaborazione del senso comune contiene parecchi elementi di verità ma non tiene conto, da un lato, che l’emergere della corruzione è di per sé un fatto positivo anche se estremamente preoccupante date le sue dimensioni, e, dall’altro, che la responsabilità a cui fa riferimento è di tipo giuridico, cioè deriva da una norma che impone un dovere. Su questo piano l’ordinamento giuridico è assai complesso e suddivide la responsabilità in civile, penale, patrimoniale e così via. Dunque sarebbe più opportuno affermare che nessuno in Italia si assume la responsabilità giuridica. Anzi, il ginepraio di leggi e norme è utilizzato proprio per farla franca. In proposito basti pensare all’uso spregiudicato dell’istituto della prescrizione.
Raramente e per lo più di sfuggita nelle chiacchiere dei bar e dei talk-show si sente parlare di responsabilità morale. Probabilmente perché è la più difficile da cogliere in quanto strettamente connessa con la dimensione culturale dove il criterio di imputabilità per la mancanza di responsabilità si intreccia col portato storico di un Paese coinvolgendo interi gruppi sociali e in particolare i ceti dominanti. Eppure la riflessione sul concetto di responsabilità è andata molto avanti fino a implicare con Hans Jonas l’estensione di tale concetto alle conseguenze future delle azioni umane. Insieme alla bioetica la questione ambientale era una di quelle che stavano maggiormente a cuore al filosofo tedesco. Jonas esortò la tecnologia a prendere consapevolezza dei suoi effetti deleteri sulla biosfera sostenendo con forza il criterio di responsabilità umana nei confronti della natura.
Il precetto che formulò non ammetteva equivoci: “Agisci in modo che le conseguenze della tua azione siano compatibili con la sopravvivenza della vita umana sulla terra”. Jonas scrisse queste parole nel 1979 e il suo libro, “Il principio di responsabilità“, ebbe grande risonanza e continua a esercitare la sua influenza ancora oggi. Ma, come è sotto gli occhi di tutti, non sembra abbia convinto le élite al potere, o se non altro non la sua maggioranza. E proprio il potere – la sua conquista, detenzione e diffusione – pare costituire oggi il fattore maggiormente critico in rapporto all’idea di responsabilità. Si tratta allora di stabilire, se non la natura, quantomeno alcune caratteristiche determinanti del potere nella nostra società.
Gli ultimi tre decenni hanno sancito un passaggio storico: la politica sta diventando sempre più l’ancella dell’economia. In parole povere i Consigli di Amministrazione delle grandi imprese, delle banche, delle assicurazioni e le organizzazioni degli imprenditori condizionano pesantemente le decisioni dei partiti e dei parlamenti in diverse materie. La vulgata giornalistica e alcuni osservatori sociali sostengono che si tratta di un fenomeno tipico delle democrazie mature e che non c’è nulla di cui preoccuparsi. È così negli USA e dunque deve essere così ovunque. Francamente pensiamo l’esatto contrario perché da quando il mercato domina incontrastato sulla società la responsabilità nei confronti del prossimo, dell’ambiente e del futuro sembra arretrare più che avanzare.
Tant’è che la politica cerca di correre ai ripari. L’Unione Europea ad esempio ha da tempo istituito tutta una serie di norme finalizzate a incentivare la responsabilità sociale dell’impresa. Per ottenere determinate certificazioni le aziende si confrontano con le implicazioni etiche del loro agire impegnandosi a rispettare determinati standard a tutela dei lavoratori e del territorio. La discussione sull’efficacia delle raccomandazioni da parte dell’Unione Europea è aperta e tra gli economisti c’è chi sostiene che la corporate social responsibility sia più un fatto di immagine che di sostanza. Senza entrare nel merito del dibattito di certo la questione ambientale è ormai un’emergenza planetaria: consumiamo più risorse di quante il pianeta ne produca e il riscaldamento globale sta generando pesanti sconvolgimenti climatici.
Papa Francesco con la pubblicazione dell’Enciclica sulla cura della casa comune, “Laudato sì‘”, ha assunto una posizione molto ferma: occorre cambiare stile di vita, occorre maggior senso di responsabilità da parte di tutti. Quanto Papa Francesco abbia colto nel segno lo dimostra la tiepidissima accoglienza della stampa mainstream rispetto alla sua proposta di uno “sviluppo sostenibile integrale”.
Un secondo fattore che caratterizza il potere nelle nostre società è costituito dal primato del consumatore sul cittadino. Zygmunt Bauman è senz’altro uno dei sociologi che maggiormente hanno insistito su questo punto ritenendolo centrale nella sua elaborazione della modernità liquida, dove nulla è permanente e non ci sono valori di riferimento. L’homo consumens è funzionale al ridimensionamento dei diritti sociali rivendicati dal cittadino. Anzi si può dire che è il tipo umano prodotto da trent’anni di neoliberismo. L’homo consumens è libero di comprare ogni cosa, di scegliere ad esempio tra una gamma sempre rinnovata di automobili ma è facilmente percepibile quanto questa libertà sia in realtà una costrizione a comprare.
Non è più il bisogno a muovere il consumatore ma il desiderio. Il bisogno è finito, caratterizza cioè una mancanza che può essere soddisfatta (se ho fame mangio e una volta sazio mi occupo d’altro). A differenza del bisogno il desiderio invece è infinito e non può mai essere soddisfatto. In gran parte i desideri dell’homo consumens sono determinati dalla pubblicità. La quale è una branca del marketing e ha tra i suoi scopi quello di far nascere nel consumatore un senso di frustrazione: il tuo corpo non è abbastanza tonico? Compra questa crema e ringiovanirai. Sempre in crisi con se stesso e sempre pronto ad acquistare le soluzioni offerte dal mercato l’homo consumens se ne infischia della responsabilità verso il mondo. Anche volendo non ha tempo, preso com’è dalla spirale produzione-consumo.
Il neoliberismo sta costruendo un mondo a sua immagine e somiglianza. Un mondo dove tutto è quantificabile e mercificabile e dove la qualità della vita si misura col conto in banca. L’ideologia che lo muove non teme di provocare guerre o catastrofi naturali. Al contrario, le calamità sono trasformate in business. Dopo i disastri si dovrà pur ricostruire. Insomma su un piano meramente affaristico l’irresponsabilità conviene quanto e talvolta più della responsabilità. Il dissesto idrogeologico del nostro Paese sta lì a dimostrarlo. D’altra parte il neolibersimo ha trovato in Italia un terreno fertile perché ben concimato dal familismo amorale. Ci rendiamo conto che questa categoria sociologica presenta aspetti critici e non è immune dallo sguardo del conquistatore. Tuttavia un nocciolo di verità lo contiene. E’ innegabile che tra gli italiani ci sia la tendenza a massimizzare nel breve termine i vantaggi materiali della propria famiglia ritenendo che anche gli altri si comportino allo stesso modo. Quest’atteggiamento è un invito alla deresponsabilizzazione nei confronti della società.
Atteggiamento che, solo per fare un esempio, possiamo constatare nel fenomeno delle discariche abusive. Si può invertire questa rotta? Si può passare dall’irresponsabilità sostenuta dal neoliberismo alla cittadinanza responsabile? Sì, si può, anche se la strada da percorrere è tutta in salita. I movimenti ambientalisti, il consumo critico, le proposte di Papa Francesco sono tutte realtà che lasciano sperare di passare dalla mancanza di responsabilità del potere al potere della responsabilità.