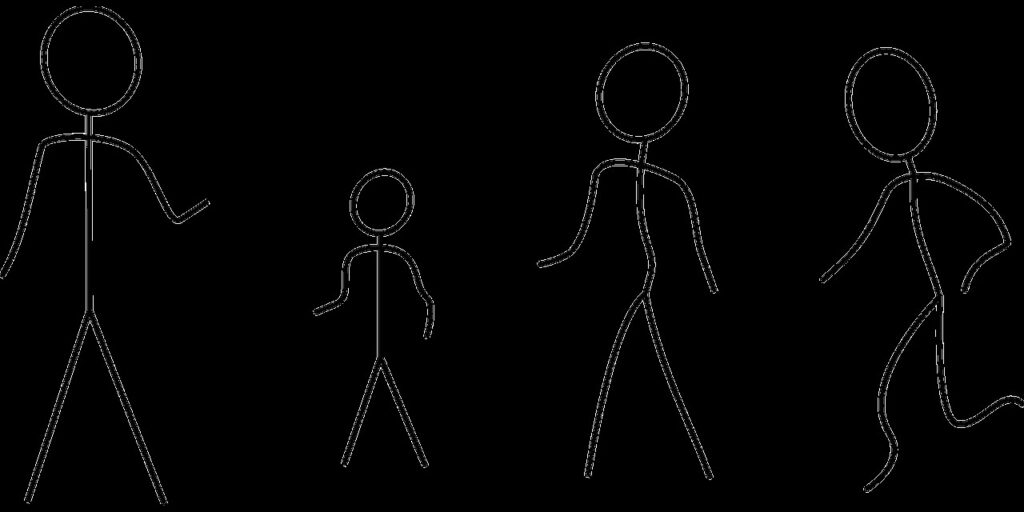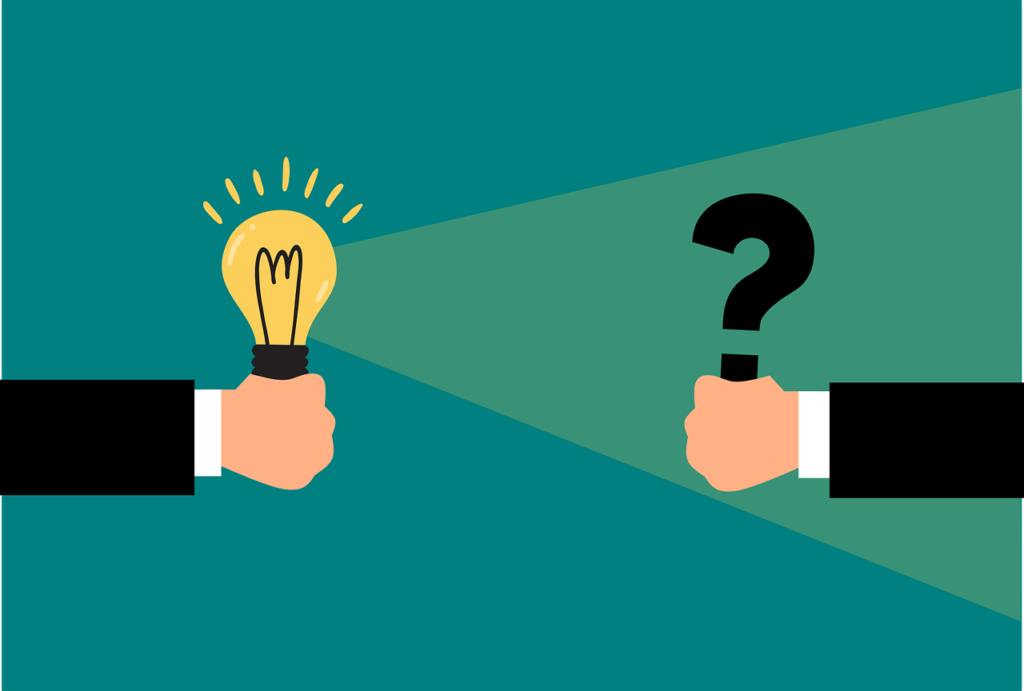Riflessioni sociologiche sul razzismo
di Giovanni Pellegrino e Mariangela Mangieri

In quest’articolo prenderemo in considerazine dal punto di vista sociologico il razzismo, un fenomeno sociale purtroppo sempre più presente nella società contemporanea.
<<== Prof. Giovanni Pellegrino
Tra i molteplici conflitti esistenti tra i gruppi sociali riteniamo opportuno occuparci dei conflitti tra gruppi etnici che sono alla base del fenomeno sociale del razzismo. A causa della globalizzazione ci troviamo a vivere in una società multietnica e multiculturale che mette a stretto contatto quotidiano individui appartenenti a diversi gruppi etnici. Questi individui possiedono un proprio patrimonio di credenze religiose, di valori ed una propria tradizione di tipo culturale. Il problema principale è costituito a nostro avviso dal fatto che la maggior parte degli individui non ha avuto il tempo di abituarsi a vivere in una società multietnica, fatta una debita eccezione per nazioni come la Francia e l’Inghilterra che avendo avuto imperi coloniali molto vasti avevano già avuto a che fare con i problemi derivanti dalle società multietniche. Tuttavia anche in queste due nazioni il razzismo costituisce un grave problema, così come lo costituisce negli Stati Uniti, la prima società multietnica della storia contemporanea.Per quanto riguarda l’Italia dobbiamo dire che la globalizzazione si è affermata in maniera rapidissima dal momento che per molti decenni è stata paese di emigrazione, oggi, tuttavia, è diventata una nazione nella quale è molto difficile controllare i flussi migratori.
A nostro avviso la globalizzazione come tutti i fenomeni sociali presenta un lato positivo ed uno negativo, dei vantaggi e degli svantaggi, che vanno compresi e accettati. Dahrendolf afferma che dal momento che non è possibile arrestare la globalizzazione bisogna necessariamente accettare sia le nuove opportunità sia i nuovi rischi ad essa collegati. Comunque non è nostra intenzione in questa sede cercare di stabilire se siano maggiori le opportunità o i problemi collegati alla globalizzazione in quanto il discorso sarebbe troppo lungo e complicato. In questo articolo cercheremo invece di limitarci a stabilire quali sono le cause sociologiche e psico sociali del razzismo nella società contemporanea. In primo luogo dobbiamo mettere in evidenza che studi condotti da diversi psicologi sociali hanno messo in evidenza che il comportamento auto preferenziale nei confronti dei propri gruppi di appartenenza, ivi compreso il gruppo etnico sembra essere una costante del comportamento umano in tutte le epoche storiche.
Tale dato di fatto ha indotto psicologi sociali a formulare interessanti riflessioni. Infatti sembrerebbe che il comportamento auto preferenziale nei confronti del proprio gruppo etnico sia sempre esistito nella storia del genere umano cosicché ci sarebbe da pensare che tale comportamento sia scritto nel Dna della razza umana. In effetti esiste una forte polemica tra gi studiosi che pensano che il razzismo sia causato da fattori di tipo genetico e gli scenziati che ritengono che il razzismo non abbia una base genetica ma sia dovuto a fattori storici e culturali. Tale gruppo di studiosi prende il nome di ambientalisti. Mentre gli studiosi che pensano che il razzismo abbia una base genetica prendono il nome di innatisti. Esiste poi un terzo gruppo di studiosi che pensano che il razzismo sia dovuto sia a fattori genetici, sia storici, sociali e culturali.
All’interno di questo terzo gruppo di studiosi ce ne sono alcuni che pensano che il razzismo sia soprattutto dovuto a fattori genetici e in parte minore a fattori sociali e storici e altri che ritengono che esso sia dovuto soprattutto a fattori ambientali e in misura minore a fattori genetici. A nostro avviso il razzismo e molti altri comportamenti umani sono dovuti in parte a fattore di origine genetica ed in parte a fattori derivanti dall’ambiente socio- culturale nel quale gli individui si trovano a vivere. Nel caso specifico del razzismo se uno delle sue cause( il comportamento autopreferenziale nei confronti del proprio gruppo etnico) ha una base genetica, le altre cause del razzismo hanno chiaramente un’origine sociale.
Nel fare un esempio concreto molti conflitti di tipo razziale nascono dal desiderio dei gruppi etnici di accedere a terminate risorse materiali entrando in competizione con altri gruppi etnici. Ad esempio il razzismo che esiste in alcuni paesi nei confronti degli immigrati è in buona parte dovuto al fatto che essi svolgono una funzione sostitutiva nei confronti degli abitanti del luogo. In alcuni settori del mercato del lavoro caratterizzati da salari bassi o addirittura dal lavoro in nero, gli immigrati sostituiscono gli abitanti del luogo. Tale funzione sostitutiva resa possibile dal fatto che gli immigrati accettano salari più bassi degli altri lavoratori dà luogo a fenomeni di razzismo che altro non sono che una lotta tra poveri. Parliamo di lotta tra poveri perché gli immigrati possono entrare in competizione quasi esclusivamente con quei lavoratori che devono accontentarsi dei lavori meno pagati e più faticosi.
Anche un’altra causa del razzismo, ovvero i pregiudizi nei confronti dei rappresentanti di altre gruppi etnici non ha una causa genetica ma è dovuta alla mancanza di dati reali sul comportamento degli immigrati. Infatti se è vero che alcuni immigrati compiono reati di vario tipo è altrettanto vero che non bisogna fare di tutta l’erba un fascio. Molti dimenticano che la maggior parte degli immigrati sono persone oneste che adottano comportamenti irreprensibili. Inoltre i pregiudizi che nascono dal pensiero stereotipo di tipo non neutrale determinano una alterata percezione della realtà. Tale percezione della realtà fa in modo che vengano attribuite ad immigrati appartenenti ad un dato gruppo etnico caratteristiche negative che sono proprie di altri gruppi di immigrati. Naturalmente molti pregiudizi nascono dalla cosiddetta paura del diverso che rende molto difficile esprimere giudizi oggettivi e motivati gli appartenenti ad altri gruppi etnici. In effetti gestire rapporti interpersonali con individui appartenenti ad altre razze e altre culture che siano in grado di terminare vantaggi psicologici, richiede il superamento di una serie di barriere comunicative create dai pregiudizi e dalla paura di mettere in discussione la propria identità culturale.
In sintesi noi crediamo che bisogna entrare nell’ordine di idee che esistono individui che conviene frequentare ed individui che conviene evitare sia nella razza bianca sia nelle altre razze che la globalizzazione ha portato nel mondo occidentale. In altri termini non bisogna mai cadere in generalizzazioni immotivate che trovano la loro origine nel pensiero stereotipo di tipo non neutrale. Infine l’ultima causa del razzismo che niente ha a che vedere con i fattori genetici è la volontà di difendere le proprie radici storiche e culturali, che secondo alcuni sarebbero messe in pericolo dalla creazione delle società multietniche e multiculturali. Tale tipo di razzismo viene denominato differenzialista in quanto ritiene che si debbano mantenere intatte le proprie radici culturali. Tale tipo di razzismo parte dal presupposto che i bianchi non avrebbero niente da imparare dagli altri gruppi etnici. Appare evidente che si tratta di un razzismo che si basa su una forte concezione etnocentrica. Noi riteniamo che non sia accettabile che i bianchi non abbiano niente da imparare dagli altri gruppi etnici e dalle altre culture dal momento che noi siamo convinti che gli scambi interetnici siano un’occasione di arricchimento per tutti i gruppi etnici esistenti sul nostro pianeta. Vogliamo concludere il nostro articolo mettendo in evidenza che il razzismo nei casi estremi determina anche episodi di inaudita e gratuita violenza nei confronti di individui appartenenti ad altri gruppi etnici.
Prof. Giovanni Pellegrino
Prof.ssa Mariangela Mangieri