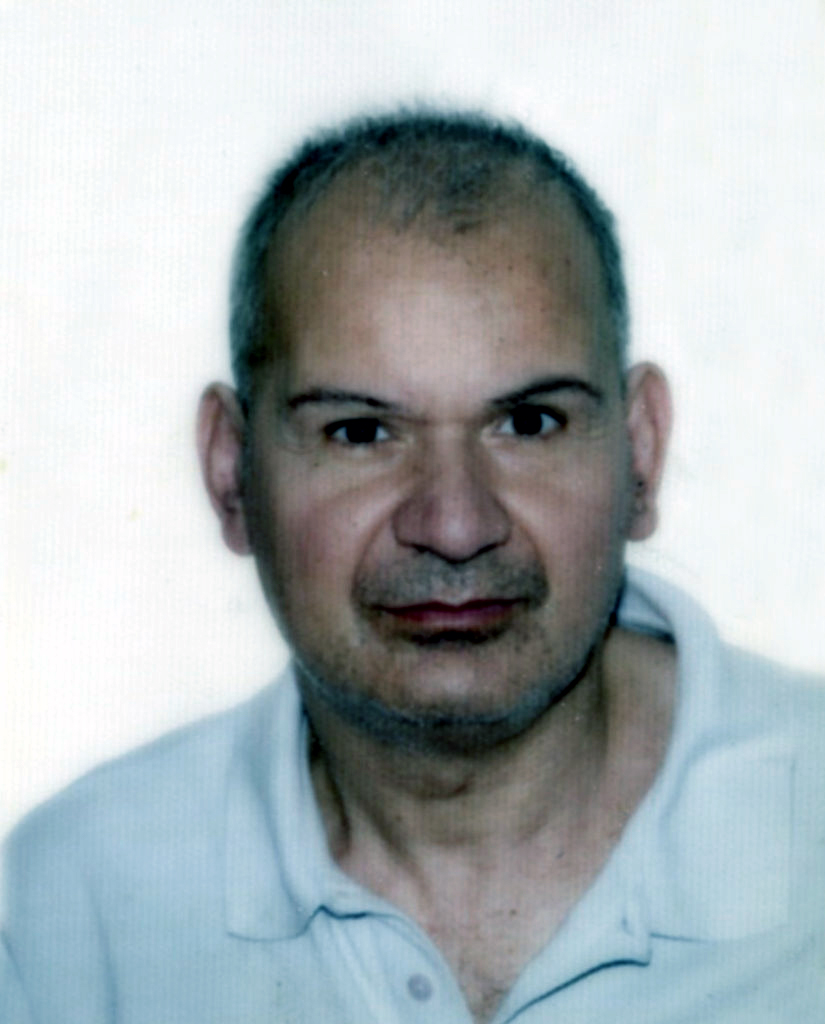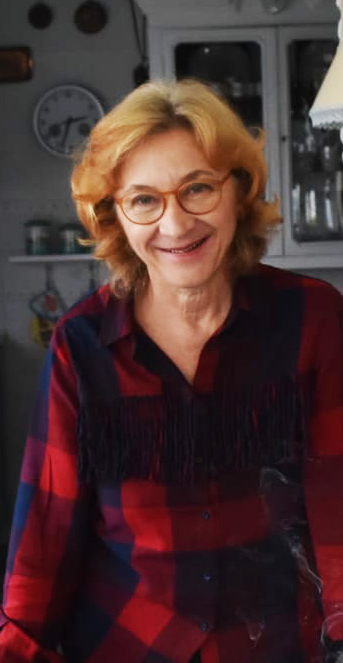LA MORTE, LA SALUTE, LA MALATTIA E LA QUALITÀ DI VITA
di Simonetta Vernocchi

La morte e il lutto
L’educazione alla morte deve far parte «della educazione» e non demanderei alla scuola o ad altri un compito proprio della famiglia. Il compito di accompagnare la persona giunta al termine del proprio cammino non può essere solo una «mansione» sanitaria, ancor meno la missione del medico o dell’infermiere. Forse un tempo era il sacerdote a farsi carico del conforto del morente e del supporto alla famiglia, ma oggi non è più così.
<<== dott./ssa Simonetta Vernocchi
Aiutare nel bilancio di vita chi disperato si trova impreparato ad andarsene spetta davvero ai sanitari? E sostenere nel lutto la famiglia?
Personalmente lo vedo come un compito dei genitori quando educano i propri figli, della famiglia in toto di fronte ad un anziano o un malato, della Chiesa o per chi vede una vita oltre la morte, forse in parte anche della scuola.
E poi?
La sociologia, la psicologia e la filosofia devono avere come obiettivo anche quello di educare alla morte, ciascuna per la parte che compete.
Ciascuno dovrebbe imparare nel corso della vita ad accogliere la fine come parte del proprio percorso terreno, prepararsi alla morte. Invece si usano le perifrasi, è venuto a mancare, è dipartito, si è sottratto all’affetto dei suoi cari, è scomparso precocemente, è accaduto l’imprevedibile, è venuto meno e non si cita la parola morte.
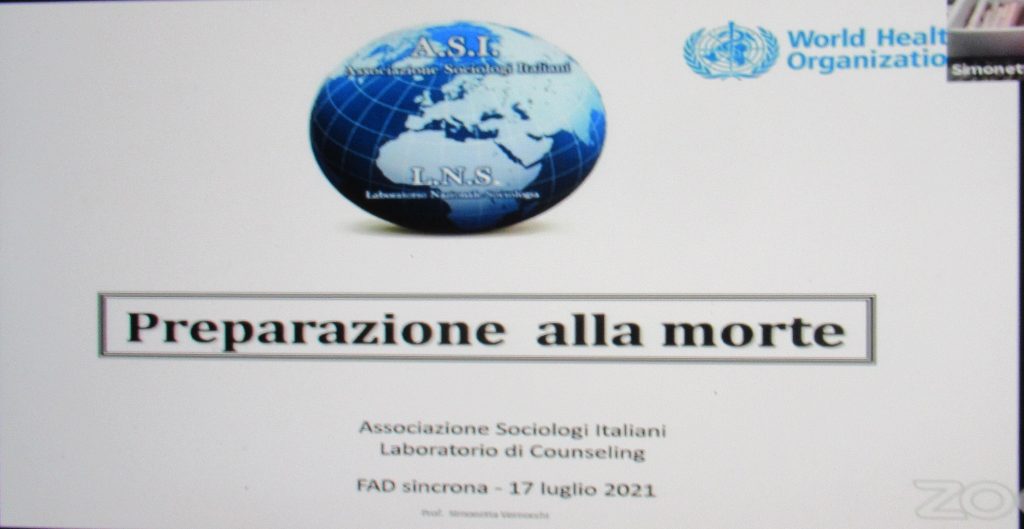
La vita umana ha un suo esordio ed una sua fine, e se la fine non avviene a causa di un trauma o di suicidio, avviene necessariamente per malattia: morire di malattia è un evento naturale. È la norma. Allora perché è così difficile parlarne? Spesso il medico è l’unico interlocutore per le persone giunte a fine vita, come se la morte altro non fosse che il fallimento della medicina, come fosse il risultato di un errore nel processo decisionale o terapeutico di qualcuno. La comunicazione con la persona morente e con la sua famiglia deve tener conto delle caratteristiche dell’individuo, della sua storia, del suo contesto sociale e colturale, dello stato emotivo, del bisogno di sapere o del rifiuto della verità che viene proposta.
Il lutto ha un valore personale nell’espressione del dolore, sociale nella condivisione dello stesso, talvolta agiamo il lutto anticipatorio per cercare di esorcizzare il dolore. E quando il dolore della perdita non se ne va? Anche dopo 30 o 40 anni ancora sembra riviverlo? Ecco il lutto patologico.
Trovare le parole giuste, il contesto contenitivo, l’empatia necessaria ci aiuta a svolgere al meglio uno dei compiti più importanti e difficili: aiutare a congedare i nostri cari da questo mondo, trovare un modo per sentirli comunque vicini, riuscire a voltare pagina. La modalità di comunicazione “corretta” rispetto al lutto si può apprendere, sia facendo tesoro degli studi scientifici in materia, sia condividendo le proprie esperienze. In contesti particolari come i reparti di pediatria, neonatologia, ostetricia, o di area critica come terapia intensiva, pronto soccorso, la comunicazione della morte è più difficile perché la morte stessa qui davvero pare fuori luogo, non è mai attesa.
Di grande attualità sono i temi delle direttive anticipate e del testamento biologico, definendo le condizioni di malato terminale, di stato vegetativo, di stati di minima coscienza e la condizione definita locked-in syndrome si possono fare delle distinzioni e definire i campi di applicazione dell’eutanasia e della sospensione delle cure per astensione terapeutica. Consideriamo infine la condizione di malattia terminale oncologica piuttosto conosciuta e la non oncologica di fatto più frequente. In questo cammino di consapevolezza e di accompagnamento la figura del medico non può essere la sola, lo spazio per figure professionali della tradizione come l’infermiere, il sacerdote o lo psicologo sono gradite ma spesso poco reperibili. Figure nuove come il counselor socio-olistico possono essere preziose.
Definizione dello stato di salute e di qualità di vita
Se chiediamo ad un gruppo di studenti di una qualsiasi scuola superiore se hanno idea sia la salute tutti risponderanno di certo con una di queste definizioni: «l’assenza di malattia», «lo sta bene con sé stessi» «la capacità di adattarsi» e cosa sia la malattia lo si definisce in negativo. Nei libri di testo un po’ datati di scienze mediche troviamo definizioni simili un po’ più elaborate: «la mancanza di impedimenti alle funzioni dell’organismo o alla sua sopravvivenza», «salute come condizione o qualità dell’organismo umano che consente un funzionamento adeguato in date condizioni genetiche o ambientali», «capacità di efficiente esecuzione delle funzioni biologiche corporee, in una vasta gamma di condizioni ambientali mutevoli». La definizione di salute secondo la Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO, 2004) “stato di benessere in cui l’individuo indirizza le proprie abilità, è in grado di gestire le normali situazioni di stress, di lavorare produttivamente e fruttuosamente, e di dare un contributo alla propria comunità”. La parola malattia non viene neppure menzionata. La salute ha a che fare con il lavoro, con la produttività con la comunità.
La definizione di qualità di vita secondo la Organizzazione Mondiale della Sanità è stata messa a punto dal gruppo di studio definito WHOQOL o WHO Quality of Life nel 1995, come “la percezione da parte degli individui della posizione che occupano nella propria vita, all’interno della cultura e del sistema di valori in cui vivono, ed in relazione ai propri obiettivi, aspettative e parametri di riferimento ed interessi”. Anche per la qualità di vita non si parla di dolore, di sofferenza, di malattia, ma di valori, di cultura, di obiettivi. Queste sono sicuramente definizioni pre-pandemiche. Non possiamo non considerare il dolore, la morte, la malattia, la sofferenza e per contro tutto ciò che procura gioia, felicità, soddisfazione
Se chiediamo al solito gruppo di studenti di una scuola superiore cosa procura a loro gioia, felicità, soddisfazione risponderanno secondo le affermazioni riportate di seguito.
- Star bene con sé stessi.
- Successo sportivo.
- Fare volontariato.
- L’indipendenza.
- Trovare l’anima gemella con cui condividere piccole gioie famigliari, fare focolare.
- Acquisire autostima.
- Riuscire ad avere anima e corpo indivisi.
Adulti, bambini e anziani valutano la qualità di vita in modo è diverso, negli anziani il dolore e la malattia occupano un posto abbastanza costante. Nell’anziano ammalato si parla di piccole gioie anche nella malattia, di riacquisire indipendenza, di essere nuovamente autonomo. Inoltre, il lutto e il distacco possono condizionare le condizioni di ciascuno. Nel post-covid ciascuno dovrebbe aver appreso la bellezza delle cose semplici, importanza del tempo.
La maggior parte delle persone, indipendentemente da età e sesso, identifica come stato di gioia, felicità le esperienze riportate di seguito.
- Ritrovare, ricongiungersi con una persona cara dopo un certo tempo.
- Le relazioni sessuali soddisfacenti danno sicuramente emozioni complesse: bramosia, desiderio, eccitazione fino al sollievo dopo l’orgasmo.
- La nascita di un figlio che comprende: eccitazione, lo stupore, il sollievo, la gratitudine, la fierezza è considerata dai più la più grande gioia.
- Lo stare insieme alla persona amata (partner).
- Relazioni famigliari amorevoli (siano esse reali, ricordate, immaginate, sublimate).
- Godere di salute buona ed assenza di dolore.
Strumenti di misurazione della qualità di vita e buona salute
I criteri dell’WHO Quality of Life, stabiliti dal gruppo di studio 1995 poi modificati nel 2010, per renderli più oggettivi ed applicabili a tutti gli individui, li ritroviamo anche nella «psicologia della salute» (La psicologia della salute Antonella delle Fave e Marta Bassi ed. Utet, 2013).
Tali criteri considerano una visione integrata (olistica) dell’individuo in cui lo stato di benessere, piuttosto che l’assenza o la presenza di malattia, è stimabile nei sei ambiti (definiti anche domini) di: salute fisica, area psicologica, indipendenza, relazioni sociali, ambiente, religione e credenze personali. Questi ambiti rappresentano un tentativo di misurazione transculturale della qualità della vita.
| Dominio 1 | Salute fisica |
| Dolore e disagio | |
| Energia e stanchezza |
| Sonno e riposo | |
| Dominio 2 | Area psicologica |
| Sentimenti positivi | |
| Pensiero, apprendimento, memoria, concentrazione | |
| Autostima | |
| Immagine corporea ed aspetto fisico | |
| Sentimenti negativi | |
| Dominio 3 | Indipendenza |
| Abilità della vita quotidiana | |
| Dipendenza da farmaci e trattamenti | |
| Capacità lavorativa | |
| Dominio 4 | Relazioni sociali |
| Relazioni personali | |
| Sostegno sociale | |
| Attività sessuale | |
| Dominio 5 | Ambiente |
| Senso di sicurezza e incolumità fisica | |
| Ambiente domestico | |
| Risorse finanziarie | |
| Assistenza sanitaria e sociale: disponibilità e qualità | |
| Opportunità di acquisire nuove conoscenze e abilità | |
| Partecipazione e nuove opportunità di ricreazione e di svago | |
| Ambiente fisico | |
| Trasporti | |
| Dominio 6 | Spiritualità, religione e credenze personali |
| Senso di connessione con un essere o forza spirituali | |
| Significato della vita | |
| Reverenza suggestione | |
| Utilità e integrazione tra mente, corpo ed anima | |
| Forza spirituale | |
| Pace, serenità, armonia interiori | |
| Speranza ed ottimismo | |
| Fede | |
| Qualità di vita generale |
| Ad ogni dominio viene attribuito un punteggio | |
| La somma dei punteggi identifica lo stato di salute |
I risultati dell’applicazione di questa tabella hanno “limiti” dati dalle caratteristiche personali dell’individuo, in particolare il peso dell’esperienza religiosa che riesce a condizionare gli altri ambiti. Pertanto, nella valutazione dei risultati occorre specificare se si tratti di persona religiosa o meno.

Valutazioni e contenuti oggettivi e soggettivi
Nella valutazione della salute dell’individuo si devono distinguere criteri oggettivi intesi come salute fisica misurabile e soggettivi intesi come salute percepita dall’individuo circa il proprio stato. Si distingue anche un contenuto oggettivo ed uno soggettivo. Il contenuto oggettivo è misurabile e consiste nella diagnosi medica di patologia. Il contenuto soggettivo è la variabile di soddisfazione e di felicità di un individuo.
Se incrociamo i 4 criteri otteniamo una tabella
| Contenuto | Valutazione | Valutazione |
| Oggettiva | Soggettiva | |
| Oggettivo | I | II |
| Soggettivo | III | IV |
I gruppo: contenuto oggettivo e valutazione oggettiva: valutiamo una persona sulla base del fatto che sia felice e con esami medici perfetti. Si sente felice, si sente bene ed oggettivamente si sente bene.
II gruppo: contenuto oggettivo, valutazione soggettiva: valutiamo una persona sana ma depressa. Gli esami medici non rilevano alcun problema fisico, né disturbo psichiatrico, ma la persona non è felice, si sente depressa. Certo chi ha subito un lutto, una perdita grave sia in termini di affetti, che di lavoro, o di altra delusione ha ragione di non essere felice, pur non soffrendo di alcuna patologia psichiatrica.
III gruppo: contenuto soggettivo e valutazione oggettiva: valutiamo la felicità di una popolazione in base al tasso di suicidio. È un dato significativo e difficilmente confutabile anche se in certi contesti può essere camuffato da incidente domestico per esempio. Nel «Health for the world’s adolescents» l’OMS evidenzia come nei giovani di tutto il mondo, di età compresa tra i 10 e i 19 anni, il suicidio sia la terza causa di morte dopo gli incidenti stradali e l’Aids. A livello mondiale si colloca fra le tre principali cause di morte per le persone di età compresa tra i 15 e i 44 anni e i tentativi di suicidio sono fino a 20 volte più frequenti dei suicidi effettivi e, se a quelli riusciti aggiungiamo i tentativi non riusciti, allora diventa la prima. Nelle nazioni industrializzate il suicidio arriva a essere la seconda o la terza causa di morte tra gli adolescenti e i giovani adulti.
IV gruppo: contenuto soggettivo e valutazione soggettiva: valutiamo la felicità con schede di autovalutazione. Sicuramente molto di questa indagine può essere manipolata o semplicemente può risentire del tipo di campione. Mi sembra quindi evidente che non è assolutamente facile né scontato utilizzare scale per valutare lo stato di salute di un individuo e molto in ogni caso, deve essere lasciato alla sensibilità del valutatore.
Diritto alla salute e diritto alle cure

Il diritto alla salute e la libertà di scelta terapeutica sono sanciti dall’art. 32 della Costituzione italiana:
«La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana».
Sorgono alcune domande che riportiamo di seguito. Il diritto è alla salute o il diritto è alla cura? E se la terapia fallisce, ho diritto al risarcimento? Posso imporre un trattamento sanitario obbligatorio? Posso imporre un accertamento sanitario obbligatorio? Negli intenti del legislatore questo articolo tutelava gli indigenti, mirava a fornire cure gratuite ed un livello minimo di assistenza. Oggi però abbiamo assistito ad un cambiamento: la salute è un diritto e la morte è il fallimento delle pratiche di cura. Si cerca immediatamente il colpevole.
Era prevenibile, era una morte evitabile? Chi ha sbagliato dovrà pagare! Certo siamo 7 miliardi, a tutti prima o poi toccherà di morire, nei prossimi 100 anni avremo 7 miliardi di morti, saranno 7 miliardi di errori medici? Di fallimenti terapeutici? Grazie alla pandemia abbiamo capito che se non proprio la morte, la malattia può colpire chiunque senza preavviso, ricchi, poveri, potenti, diseredati, colti, ignoranti, bimbi ed anziani, e proprio i detentori del «sapere medico» sono i primi ad andarsene, nonostante l’accesso alle migliori cure.
La pandemia ha messo a nudo i limiti del nostro sapere medico, ha mostrato che la cura del paziente è qualcosa di più e di differente rispetto alla semplice terapia farmacologica.
Ha evidenziato le fragilità del nostro sistema sanitario e ci ha obbligato ad operare scelte in aperta contraddizione con alcuni assiomi dell’articolo 32 della nostra costituzione: siamo stati privati della nostra libertà, siamo stati obbligati alle cure.
Credo che dovremo parlare di modalità di cure pre-pandemia e post-pandemia.
Modifichiamo il nostro approccio al paziente, cerchiamo di essere più umili e più disponibili al confronto.
Dott. Simonetta Vernocchi – Medico e Sociologa ASI