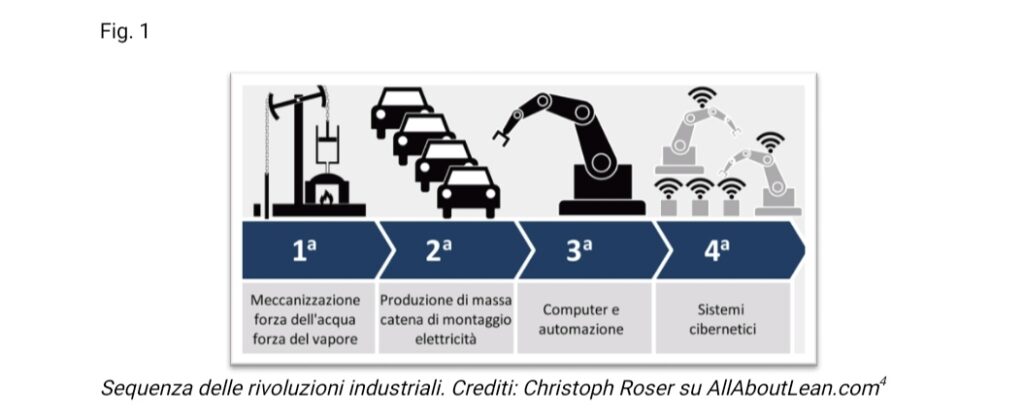Niente è per sempre. Diagnosi sociologica di una massima mediatica
di Patrizio Paolinelli

Sintesi. Niente è per sempre. Diagnosi di una massima mediatica.
Cosa si nasconde dietro un motto apparentemente innocuo come “Niente è per sempre”? Si nasconde una visione del mondo che dà per scontata la provvisorietà delle relazioni sociali nella vita di un individuo. La legittimazione di tale visione è stata sostenuta dai mezzi di comunicazione e si è ulteriormente consolidata nel senso comune. Su questo modo di percepire il tempo giusto da dedicare al prossimo e al mondo ci siamo interrogati da un punto di vista critico. L’analisi ha rivelato quanto la predilezione per il discontinuo costituisca, da un lato, il classico granello di sabbia che inceppa gli ingranaggi della riproduzione sociale ormai inadatti a un mondo in transizione; dall’altro, favorisca l’accettazione passiva delle trasformazioni economico-sociali che oggi investono la vita degli individui e della collettività.
Input.
La campagna comunicativa fu breve ma intensa. Pochi anni prima della pandemia da Covid-19 alla radio, in Tv e su Internet si sentiva ripetere spesso: Niente è per sempre. A pronunciare queste parole erano i più diversi personaggi: attori, cantanti, comici, sportivi, politici, scrittori, giornalisti, influencer e comparse varie. La sentenza divenne così popolare da vibrare nelle conversazioni quotidiane del grande pubblico. I bersagli del nientesemprismo erano i più diversi: dalla vita lavorativa alle scelte politiche, dagli orientamenti culturali alle storie d’amore e così via. Poi è arrivata la pandemia e “Niente è per sempre” scomparve dalla ribalta mediatica. Finita l’emergenza sanitaria la sentenza è tornata solo occasionalmente a fare capolino sui mezzi di comunicazione. Evaporata nel nulla? No, semplicemente non è stato più necessario insistere. La campagna comunicativa aveva raggiunto il suo obiettivo: oggi Niente è per sempre costituisce un input (un frame direbbero i linguisti cognitivisti) che permette di elaborare una visione del mondo basata principalmente su due convinzioni: 1) tutte le relazioni sociali sono all’insegna del provvisorio; 2) rifiutare il Per sempre lascia la porta aperta a occasioni, avventure, piaceri.
Blasé. La temporaneità delle relazioni sociali e il mondo di opportunità che spalanca ha il suo modello nell’individuo blasé così ben osservato da Simmel.
Ma né Simmel né i sociologi che a lui si ispirarono tentarono di connettere in maniera critica l’indifferenza metropolitana con la realtà storica di un capitalismo che forgiava i rapporti umani a uso e consumo della borghesia. La quale è blasé di natura. Ossia: indifferente e insensibile verso l’altro (salvo inconfessabili convenienze o pelose filantropie). Si dirà che anche in passate civiltà l’indifferenza e l’insensibilità facevano parte del panorama sociale. Ma intanto, che ci sia stato qualcuno come noi o peggio di noi non può costituire un’assoluzione, e poi si tratta di un’astrazione che non permette di cogliere la qualità particolare dell’indifferenza e dell’insensibilità in società fondate sulla merce. Il blasé ben si adatta a questo tipo di società e si è imposto a tal punto da diventare un atteggiamento necessario anche per chi avrebbe tutto l’interesse a non essere snob, scettico, o peggio ancora cinico. Comunque sia, il blasé di un secolo fa si è evoluto e la chiave per comprendere il suo sviluppo risiede in tre storiche mosse attuate dal capitalismo nei confronti dei dominati: 1) averli espropriati del proprio tempo come produttori; 2) averli impiegati a tempo pieno come consumatori; 3) averli socializzati come feticisti della merce, i famosi prosumer.
Fiabe.
Per sempre e la sua negazione, Niente è per sempre, costituiscono due facce della stessa medaglia: una appannata, l’altra sfavillante. 1) Faccia appannata. Per sempre ipoteca il tempo e punta alla realizzazione di un’utopia collettiva, fosse anche quella minima delle vecchie fiabe: E vissero felici e contenti. A suo modo la fiaba è iscritta in un tempo escatologico: dopo tanto penare, finalmente la felicità per tutti: principi, principesse e plaudenti folle contadine. 2) Faccia sfavillante. Niente è per sempre libera il tempo da qualsiasi ipoteca e punta alla realizzazione di un’utopia soggettiva, quella massima della fiaba mediatica: la vita lussuosa delle star dello spettacolo. Sul piano cognitivo è la strada più facile perché la vita lussuosa non va immaginata. Si presenta a chiunque posi gli occhi su qualsiasi schermo o sulle vetrine nelle vie dello shopping. Lo sguardo si fa tattile e il sogno dell’happy end è a portata di mano.
Mediatizzato.
Attraverso i suoi protagonisti i media mettono il suggello a ciò che è già avvenuto in una vita quotidiana immersa nella spettacolarizzazione del Sé. Immersione che destruttura il mondo della fabbrica produttrice di manufatti (la casa automobilistica) e lo ristruttura intorno alla fabbrica produttrice di immagini (la casa cine-televisiva). La produzione di immagini è di un’abbondanza alluvionale, spesso gratuita, persino autoprodotta tramite i social network e completamente mercificata. In breve, è fatta per non durare. Tanto basta a rendere sufficiente una semplice parola d’ordine come “Niente è per sempre” per ridare senso a una realtà quotidiana che ha sempre meno senso. Salta subito agli occhi che una sintesi temporale di questo tipo lubrifica i modelli culturali dominanti. Chi balla al ritmo del Niente è per sempre fa parte a pieno titolo delle agenzie di socializzazione in costante ascesa quali i mezzi di comunicazione: il mediatizzato può scimmiottare sui social network quel che vede in Tv, nei video musicali, negli spot pubblicitari e nelle copertine patinate. Ed è legittimato a trascurare agenzie di socializzazione in costante discesa quali la famiglia, la scuola, la chiesa, i partiti, i sindacati: il mediatizzato può sopportarle o addirittura ignorarle ottenendo così la patente di rivoluzionario/a dalla Tv, dai video musicali, dagli spot pubblicitari e dalle copertine patinate.
Rivoluzione.
Da quando i rivoluzionari anticapitalisti sono stati politicamente sconfitti, la patente di rivoluzionario/a è generosamente distribuita dai media a parecchi personaggi pubblici o aspiranti tali. Gli spazi di manovra di questi rivoluzionari sono ben definiti: la tecnologia e il costume. Non resta allora che chiedersi: cos’è una rivoluzione politica? È un’accelerazione del tempo. In quanto tale ha vita breve. È un momento: un momento entusiasmante, un momento in cui tutto cambia, un momento destinato a segnare il futuro. Passato il turbine rivoluzionario si fanno i conti: o si è vinto, o si è perso. Normalmente una rivoluzione politica comporta forti rischi (carcere, condanne a morte, torture) e spesso i giovani sono tra i più inclini a correrli. La rivoluzione tecnologica e quella dei costumi conoscono un diverso andamento: difficilmente comportano la perdita della vita o della libertà per i loro protagonisti, rappresentano buoni affari per il potere economico e sono coccolate dalla stampa. Perciò hanno dalla loro parte il tempo: da più di mezzo secolo le star cine-televisive scandalizzano incitando alla rivoluzione sessuale, da più di mezzo secolo gli araldi della rivoluzione digitale promettono un avvenire meraviglioso. Entrambi danno spettacolo.
Contraddizioni. Il motto Niente è per sempre vale anche per i dominatori?
No, perché sono i padroni del tempo. In quanto tali decidono le regole del gioco. Per esempio legittimando la concorrenza come regola di vita (chi ha più ascolti? Chi ha più follower?). La posta in gioco? Il successo, il sex-appeal, i soldi. Per conseguire questi risultati occorre un ordine del tempo molto ben strutturato. Il problema si pone quando tale ordine vacilla perché i dominatori esplorano nuove strade per mantenere il potere. In tal caso si parla di società in transizione. Si parla della nostra società. Niente è per sempre non è che un diabolico dettaglio di questa transizione. Dettaglio rivelatore di una società che cresce mentre decresce, che migliora mentre peggiora, che avanza mentre arretra. Chiamiamo questi movimenti di unità e opposizione con un nome di vecchia conoscenza: contraddizioni. Anziché limitarsi a certificarle, la sociologia critica ha il compito di analizzarle e combatterle con tutte le proprie forze.
Fuga. La supremazia del momentaneo sul duraturo si fonda sull’evanescente concretezza dell’immagine.
Tutto cambia davanti allo schermo e non c’è una puntata uguale all’altra. Tuttavia la durata non scompare. Come potrebbe? Senza un qualche tipo di durata non ci si impadronisce del tempo. Per questo pubblicità, video musicali e videogiochi funzionano sulla ridondanza. Per questo generi, sottogeneri e serie televisive rassicurano i mediatizzati: tutto passa, tutto resta, tutto circola. E in caso di esaurimento della vena creativa tutto ritorna: sotto forma di remake, prequel e sequel. Ecco indotta una stabilità che non subisce strappi a causa delle discontinuità della vita fuori dallo schermo. Difficoltà presagite e allo stesso tempo ignorate nella speranza che le cose non vadano come potrebbero andare, e cioè male. Ma in fondo a che scopo preoccuparsi? Tutto finisce perché dopo il matrimonio c’è il divorzio, dopo l’occupazione la disoccupazione, dopo l’alfabetizzazione l’analfabetismo. Tre evidenze che come tutte le evidenze hanno una presa notevole nella formazione degli schemi con cui i mediatizzati costruiscono la realtà del moto perpetuo. È la forza di un pensiero che non pensa. È la forza dell’ovvio. E l’ovvio non si interroga sulle cause dell’ovvietà. La sua arte è la fuga.
Felicità.
Niente è per sempre è un semplicismo. Va in crisi per un nonnulla. Basti pensare al fatto che la lingua madre è per sempre, così come i genitori e i figli. Se poi si aggiunge che una volta imparato non ci si dimentica più come si nuota o come si va in bicicletta, allora il nientesemprismo presenta troppi punti deboli per essere preso sul serio. Invece va preso molto sul serio proprio perché non regge alla minima analisi critica. La sua forza di convinzione proviene dal potere magico-sacrale dei media. Cioè da una realtà che è vicina e lontana al tempo stesso e che il mediatizzato percepisce come fonte di inesauribili rivelazioni. Dunque una realtà che possiede almeno un paio di requisiti del sovrannaturale. Oltretutto la defunta star dello spettacolo può risorgere sullo schermo in qualsiasi momento. E poi l’espressione Niente è per sempre colpisce come uno slogan pubblicitario. Offre una massima con cui chiunque può liberarsi dalle costrizioni che imprigionano il corpo, la mente, la vita. Niente è per sempre è un invito alla libertà e un modo di stare al mondo. È la formula magica della felicità.
Paradosso.
Il precetto Niente è per sempre è di tipo morale: si è liberi perché senza vincoli. Ma senza vincoli non si può vivere perché tutti hanno bisogno del fornaio e degli affetti. Come risolvere il problema? La soluzione è già contenuta nel precetto. Il provvisorio al posto del permanente, il discontinuo al posto del continuo, l’intervallo al posto della ripetizione sono temporalità che esigono rotture continue della durata. Perciò la noia incombe sulla vita del mediatizzato. E allora è bene cambiare fornaio e cambiare affetti. Dopodiché cambiare ancora. Ci si trova così in una incresciosa situazione: Niente è per sempre è Per sempre. Torna il tempo ciclico. Che ovviamente non è quello della regolarità stagionale con le sue attese e le sue attività produttive. È il tempo ciclico del consumo con le sue spese e le sue attività riproduttive: l’apericena e la discoteca, la vacanza e la festa, la movida, il concerto. È il tempo disimpegnato dei rentier. Dei giovani agiati che spendono e spandono i soldi guadagnati dai genitori. È il tempo a cui aspirano i giovani meno agiati che lavorano nei locali notturni frequentati dai coetanei più fortunati e di quelli che li riforniscono di droga.
Lavoro 1.
Nella realtà industriale di ieri il nientesemprismo non avrebbe avuto la stessa presa sul senso comune che ha oggi perché il tempo aveva traiettorie definite (scuola, lavoro, pensione) e divisioni altrettanto definite (tempo libero, tempo di lavoro). Nella società in transizione dei nostri giorni traiettorie e divisioni tendono a convergere in un’unica dimensione: la prestazione occasionale. Poiché le occasioni sono scarse nella realtà e abbondanti nei mondi delle apparenze, Niente è per sempre comporta per l’individuo: un costante lavoro di ricerca delle opportunità; l’impegno per sfruttare tali opportunità; una strategia per trovare nuove opportunità. Questo circuito che in tanti devono percorrere è accompagnato dal refrain: dimenticati il posto fisso. Di solito tali coristi sono dei mini-ulisse che hanno colto l’opportunità e sono arrivati in alto: il celebre cantante, il giornalista affermato, il famoso esperto. Tutti insieme invitano i giovani a lavorare gratis per muovere i primi passi nel mondo della produzione e presentano la workation (il lavoro associato alla vacanza) come una moda da seguire per sentirsi parte della tribù dei Millennial o della Gen Z. È una questione di stati danimo. In fondo anche uno schiavo può essere felice se non ha coscienza della propria schiavitù.
Lavoro 2.
I padroni del tempo lo sanno molto bene: gli individui hanno bisogno di lavorare per sopravvivere. Ma sembra che di lavoro ce ne sarà sempre di meno e sempre peggio pagato. Se le cose stanno così occorre adattarsi a cambiare lavoro diverse volte nel corso della vita? E come si fa? Nessun problema: cè la formazione permanente. Ma quanti sono i permanentemente formati che fanno rientrare dalla finestra il posto fisso cacciato dalla porta? Pochi. Tuttavia quei pochi segnalano ai molti che nonostante il lavoro sia scarso e malpagato è ancora un ordinatore della nostra società. Indubbiamente un ordinatore in crisi. Finora il nostro modo di produzione ha resistito mantenendo alta la tensione tra occupazione e disoccupazione, posto fisso e posto precario, debiti e crediti. Allinterno di quella tensione si potevano inventare finti lavori, opere inutili e selve di contratti a termine. Ma cosa accadrà quando il lavoro salariato non occuperà più il tempo e i pensieri di una moltitudine assai più cospicua dell’attuale? Accadrà che in barba a Monsieur Robot e Madame Intelligenza Artificiale sbarcherà comunque il lunario. E come battezzeremo questa massa di indigenti? Incontemporanei. Perché questo strano nome? Perché non avendo vincoli temporali saranno fuori dal tempo sociale. Per costoro unità standardizzate come la settimana e il mese saranno inutili e perderanno di significato. Lavorando di fantasia potremmo immaginare nel futuro una società dotata di calendario e una senza.
Lavoro 3.
La contemporaneità esige il suo tributo: il lavoro della fabbrica e dell’ufficio cede il passo alle tipicità del lavoro nel mondo dello spettacolo. Un mondo dove tutto è provvisorio. Ogni contratto è temporaneo, ogni performance un’occasione per essere notati, ogni forma di solidarietà una nota di demerito. Perciò nessuno è più imprenditore di se stesso dell’attore. E all’attore deve somigliare il salariato e lo stipendiato se vuole sopravvivere. D’altra parte, mentire ai colleghi e ai superiori non è forse una recita? Mentire a sé stessi non è forse un film di cui si è protagonisti? Il contratto è finito? Si va a caccia di un altro. Ma le risorse sono scarse, perciò procurarsi un reddito diventa una questione di vita o di morte e i concorrenti vanno eliminati. Ognuno è solo, il tempo stringe e occorre prendere le occasioni al volo: anche se retribuite poco, pochissimo, talvolta niente. L’importante è darsi anima e corpo. Non è proprio questo che fanno gli attori sul palco e davanti a una telecamera?
Free lance.
La massima Niente è per sempre ha una funzione sociale: sollecitare gli individui al cambiamento continuo per rispondere alle esigenze di qualsiasi mercato: del lavoro, dell’esperienza, dei desideri. È evidente che la sovranità dell’incertezza ha come conseguenza l’indebolimento di una delle basi fondanti di qualsiasi relazione sociale: la fiducia. Eppure persino tanti rapporti commerciali, pur blindati da norme e contratti, vacillerebbero senza un’iniezione di fiducia. Dunque Niente è per sempre non implica l’assolutismo della sfiducia sul mondo, perché in tal caso la coesione sociale andrebbe in briciole. Implica l’accettazione di una vita da free lance: nel lavoro, nell’esperienza, nel desiderio. Investimenti. I padroni del tempo lo sanno molto bene: gli individui non si isolano. Cercano di stare insieme, di dare e avere fiducia. Ma non ci riescono, o ci riescono sempre meno. E cosa fanno per appianare un bilancio troppe volte in rosso? Attingono a risorse psichiche offerte dall’industria culturale. Un’ottima fonte è la pubblicità. Per esempio si può regalare un diamante. Perché come recita un vecchio e fortunato slogan Un diamante è per sempre. Sono pochi i prodotti che fanno rientrare dalla finestra il Per sempre uscito dalla porta. Ma quei pochi segnalano che senza regolarità e aspettative la società precipita nell’anomia. D’altra parte, popolarizzare il lusso tiene in vita l’ordine economico. E l’ordine economico mantiene viva la tensione tra permanenza e impermanenza, continuità e discontinuità, aspettative realizzate e aspettative deluse. È tutta una questione di investimenti. Basta chiedersi: fino a quando un diamante è per sempre? Finché rende. Si apre al mediatizzato un problematico campo d’azione: gestire il valore d’uso dell’altro e decidere quando è esaurito il suo valore di scambio.
Egemonia.
Il conformismo può essere genericamente definito come l’accettazione passiva delle regole del gioco sociale. Categoria che va molto stretta al mediatizzato. Eppure sui social network le forme espressive sono largamente mutuate dai vecchi media. Ossia: immagini e contenuti riproducono rappresentazioni del corpo, forme estetiche, modelli di intrattenimento collaudati da tempo. Se si fa notare che si tratta di impercettibili variazioni sul tema, o peggio ancora di Tv fatta in casa, il rischio di suscitare reazioni rabbiose è molto alto. Chi può ammettere di non essere originale? La ferita all’Io sarebbe troppo dolorosa per essere sopportata. Tanto più se il tiktoker ottiene contratti pubblicitari. E per mantenerli attivi le leggi della visibilità impongono di rompere continuamente gli schemi. Per le star dello spettacolo il gioco è facilitato in virtù della loro posizione dominante sul mercato delle immagini. Per i creatori di coreografie e gag sui social network il gioco si fa duro una volta raggiunta una massa critica di utenti: occorre mantenerla e incrementarla. E allora che cosa possono mettere sul tavolo per continuare a partecipare alla partita? Il loro tempo. Con questo capitale cercano di stupire e essere stupiti, di sorprendere ed essere sorpresi. Naturalmente a vincere è il banco.
Ambivalenze.
Le sorprese sono classificate dalla sociologia come irregolarità temporali. Quando nella vita privata tali irregolarità sono ossessivamente ricercate e magari ostentate pubblicamente sui mezzi di comunicazione, le sorprese finiscono di sorprendere e per i protagonisti inizia la noia, l’insoddisfazione, il disagio del tempo vuoto. A questo punto arriva in soccorso la famosa attrice. La quale si iscrive alla piattaforma Tinder non per inseguire occasionali partner sessuali, ma nientemeno che per trovare l’anima gemella. E come lei altre belle ragazze (almeno così ci informa la stampa). Segno che il promiscuo, il provvisorio, il discontinuo non funzionano? Al contrario: funzionano proprio perché non funzionano. Detto altrimenti, funzionano bene proprio perché funzionano male. L’ordine socio-temporale non è contradditorio a caso. Produce patologie, disfunzioni e fratture che poi gli individui devono aggiustare da soli tentando, talvolta a costo di tremende sofferenze psichiche, di ricucire la trama del proprio vissuto. Come? Introducendo nella vita personale continuità, durate, regolarità. Dove? In una realtà sociale dominata da rotture, discontinuità, irregolarità. Per i più questo conflitto tra ricerca soggettiva e costrizione oggettiva è impossibile da risolvere nella vita pratica. Ma non nella vita immaginaria. Su Tinder la famosa attrice può tornare a sognare, sperare, sperimentare. E con lei gli iscritti all’app.
Chance.
Le relazioni sociali fondate sulla coscienza del provvisorio alimentano due complementari sentimenti del tempo: quello dell’impermanenza e quello della vita adrenalinica. Gli spazi in cui i due sentimenti si esprimono sono: la cornice, il recinto, l’arena. Essi corrispondono alle chances che i mediatizzati si giocano per realizzare una vita intesa come opera filmica, esibizione circense, conflitto. I media istruiscono il grande pubblico a far proprie tutte e tre le dimensioni e a mescolarle tra loro. Beninteso: il film va continuamente riscritto, l’esibizione sempre rinnovata e nell’arena non si smette mai di combattere. Se si vuole Niente è per sempre è un genere biografico. Ecco nascere la dipendenza dai social network. Ecco nascere la partecipazione attiva alla propria dipendenza. Ecco il business dell’infelicità.
Perversioni.
Ovviamente si generano conflitti tra regolarità temporali socialmente imposte (orari e calendari) e irregolarità temporali soggettivamente autodeterminate (disimpegno, spontaneità). Meno ovviamente si viene a generare uno scambio vantaggioso sia per l’individuo senza potere sia per il potere dei media. Per l’individuo senza potere perché lo stimola a cercare le novità con cui ammazzare il tempo; per il potere mediatico perché lo spinge a offrire un presente dietro l’altro da ammazzare. Per i mediatizzati Niente è per sempre si caratterizza come uno strumento di difesa: bruciare letteralmente i tempi. Per i mediatizzatori come uno strumento di offesa: produrre tempi da bruciare. Il circolo è vizioso, per non dire perverso. Però funziona. Funziona per andare oltre la fretta, oltre la velocità, oltre l’accelerazione: nell’era del capitalismo eterno. La fine della storia è certamente un’illusione. Ma è un’illusione reale con cui fare i conti.
Notturni.
Il nientesemprismo non ha nulla a che fare con l’interrogarsi sulla caducità della vita. Assume un significato solo all’interno dell’esperienza effettuale nell’era della sua mediatizzazione. La morte non appare all’orizzonte perché è la fine del mondano. Perciò non è contemplata, pur essendo il sangue sparso in grande abbondanza nell’universo dell’intrattenimento. Innumerevoli morti ammazzati scorrono davanti agli occhi di spettatori cine-televisivi e giocatori di videogame sin dalla più tenera età, facendo dello smisurato un esorcismo per schivare la falce che tutto e tutti miete. Gabbata la Nera Signora Niente è per sempre esprime una massima energetica che permette di aprire e chiudere contatti comunicativi con individui, gruppi e istituzioni dando senso ad un agire. Daccordo: è un agire per agire. Ma chi si ferma è perduto non è solo un modo di dire. È un fare che legittima agli occhi della società una sentenza morale: è bene correre da una situazione all’altra e da una sensazione all’altra; è male tutto ciò che frena la corsa e che inibisce l’eccitazione. La città che non dorme mai, il fascino della notte, le trasgressioni clandestine diventano realtà ideali per un modo d’essere, di vivere e di pensare. Un ethos che non si spegne neanche nelle ore diurne.
Non-lutto.
Nella vita quotidiana le cose non vanno lisce come in un villaggio turistico. Di solito rotture della continuità come un divorzio o un licenziamento lasciano ferite psicologiche e materiali. E i più sensibili possono provare una stretta al cuore nel gettare via un paio di vecchie scarpe. Ma negando il futuro Niente è per sempre è una di quelle massime che permette di fare il callo nei confronti di qualsiasi perdita. A curare i vuoti comunicativi con gli altri, con sé stessi e col mondo ci penseranno gli esperti. I quali scaveranno nel passato per offrire un futuro (psicologo). Oppure scaveranno nel presente per offrire un altro presente (coacher). Quanto resisterà il callo psichico alle continue perdite è un affare soggettivo. Diventa un affare sociale nel momento in cui si diffonde l’inutilità di credere in qualcosa di permanente. Il mondo appare allora molto chiaro e molto ostile. Non occorrono particolari titoli di studio per arrivare a questa conclusione: fa parte del senso comune. Come fa parte del senso comune che il denaro è il più potente mediatore del rapporto con l’altro. Sia per attrarlo quando conviene sia per respingerlo quando non conviene.
Resilienza.
Come per il giocatore d’azzardo chi fa propria la massima Niente è per sempre si trova nella condizione di prendere continue decisioni. Brivido e studio, simulazione e dissimulazione, vincere o perdere. Tutte tensioni, strategie e risultati che richiedono propensione al rischio e un complesso expertise. Con un vantaggio: anche in caso di sconfitta il dispiacere dura poco perché, volenti o nolenti, non si tarda ad assaporare il piacere di una nuova partita. Ciò che tiene insieme piacere e dispiacere è la coazione a ripetere, che, patologica un tempo, ha assunto di recente un nome taumaturgico: resilienza. Per il resiliente le partite sono tutte uguali e tutte diverse. Per fortuna si può sempre barare. La cosa si fa interessante perché come si fa a barare contro il tempo? Manipolandolo. Un esempio: per quanto tempo nella vita occorre essere resilienti? L’ideologia neoliberista non risponde chiaramente. Ma lascia intendere che si debba essere resilienti per sempre.
Finzioni.
Il mediatizzato si priva volentieri del libro. Non c’è da allarmarsi: è ovvio che sia così. E non solo perché dedica il proprio tempo ad altri strumenti di comunicazione o perché nei film quasi mai protagonisti e comparse sono ripresi mentre leggono. Ma soprattutto per due motivi. Primo motivo, perché la parola stampata non è modificabile, è fedele anche se incita all’infedeltà e col trascorrere del tempo resta identica a sé stessa: un libro è per sempre. Secondo motivo, la lettura della carta stampata è uno di quei rari momenti in cui si è davvero soli con se stessi, inaccessibili agli altri e sovrani della propria vita privata: in pratica invisibili. Per tutti questi motivi il nientesemprista coglie al volo l’occasione di presentarsi come un eretico: perché assegnare così tanto valore alla pagina stampata quando quella digitale posso modificarla a mio piacimento e se mi va farla sparire in un attimo? Certo, i file cestinati possono essere riportati alla luce da software di recupero, i messaggini cancellati ripescati dalla polizia postale e tutti siamo sorvegliati dalle Big Tech. Ma l’eresia resta. Per far felice il nientesemprista basta il suo odore. Non sa di bruciato e nessuno si scotta. È l’individualismo disperato di un individuo mutilato. Un individualismo lontanissimo dalla tradizione illuminista. In vita i Lumi più che la felicità conobbero censure e persecuzioni. Portarono al massimo delle sue possibilità la cultura tipografica e il tempo lungo della lettura. Al potere dei media digitali e del tempo reale l’illuminista non serve più. Tornano più utili gli eretici senza eresia.
Scardinamenti.
Se volessimo analizzare il nientesemprismo sul piano comunicativo giungeremmo alla facile conclusione che a indebolirsi è soprattutto il referente. Cioè, l’aggancio tra la parola e il suo oggetto. Niente è per sempre esige dunque un modesto patrimonio linguistico con cui leggere gli altri e il mondo. Meno parole scorrono tra Ego e Alter più è rapido il contatto. Tempo fa capitava di vedere in qualche film la seguente scenetta: una giovane coppia ha appena finito di fare l’amore e un partner chiede all’altro: A proposito, come ti chiami? Di solito i due si erano appena conosciuti a una festa molto alcolica. La scenetta ha funzionato così bene che non c’è stato più bisogno di replicarla e infatti non la si vede più. Tuttavia ci dice molte cose sulla percezione dei ritmi sociali. Ordini di successione come il corteggiamento prima e la consumazione dell’atto sessuale dopo, possono essere ribaltati dentro e fuori lo schermo senza provocare alcun trauma. La vacanza trasgressiva, la discoteca, il Progetto Orgasmus costituiscono situazioni in cui disarticolare consolidate ritualità ormai considerate dantan. Di buono c’è che scardinare l’ordine di successione degli eventi rende euforici e catapulta nel futuro. Di meno buono c’è che l’usa e getta fa dell’esperienza una discarica. Si può non comunicare.
Conciliazione.
A dispetto della propria tradizione Niente è per sempre necessita di alcune condizioni. Per esempio, un corpo tonico, giovane e in salute Per sempre. Sui social network ci si può imbattere nell’esibizione di madre e figlia che ballano davanti alla telecamera al ritmo di un motivetto orecchiabile. Le due donne sono bionde, in splendida forma fisica, indossano T-shirt, jeans, scarpe da ginnastica e sono quasi indistinguibili come le Barbie, di cui sono la rappresentazione vivente. Una mise, un’esibizione, una filosofia giovanilista che mal sopportano la malattia, i difetti dell’età, la mancanza di sex appeal. Niente di nuovo. La glamourizzazione del sé corporeo costituisce una sfida perenne al compiacimento e all’autocompiacimento. E da sempre l’aura che accompagna i divi cinetelevisivi è fatta proprio dal grande pubblico che ammira le star per poi ammirare se stesso. Dove collocare questo processo all’epoca del Web 2.0? Nell’appropriazione indebita dell’immagine? Nell’economia del dono? Né luna né l’altra. Semplice mitologia. Mitologia dell’eterna giovinezza. Mitologia confortante perché non si può vivere perennemente nel provvisorio. Anche il nientesemprista ha così un progetto di vita e un lavoro a tempo indeterminato: gestire il proprio corpo. È vero, altro non gli è rimasto. Ma è più che sufficiente per lenire la sofferenza di vivere in una società in cui tutto muore.
Bios.
Recita un vecchio adagio: Dalla vita non si esce vivi. Ma sarà per sempre così? Non lo sappiamo. Di certo sappiamo che nell’attuale fase di transizione le élite al potere cercano di accaparrarsi nuove risorse senza rinunciare alle vecchie. E la nuova risorsa oggi si chiama tecno-scienza. Così avanzata da sconfiggere molte malattie, ritardare l’invecchiamento e forse sconfiggere la morte. Su quest’ultima frontiera si colloca il transumanesimo. Unita dall’idea che la specie umana possa trascendere se stessa questa discussa corrente di pensiero presenta al suo interno alcune tendenze. C’è chi sostiene che dopo la morte solo il cervello può essere salvato dalla degenerazione, chi prospetta l’upload della mente di un individuo su una piattaforma, chi l’avanzata dei cyborg, chi pensa alla vita eterna, chi più modestamente a una vita millenaria e così via. Come andrà a finire nessuno lo sa. Tanto più se, come fanno i transumanisti, si isola la tecnologia dalla politica pensando che goda di vita autonoma. Comunque sia, si può ragionevolmente ipotizzare che la storica linea del tempo umano (nascita, educazione, lavoro, riproduzione, vecchiaia e morte) sia destinata a subire forti trasformazioni. Quello che il transumanesimo lascia in sospeso sono almeno tre questioni: il sé dell’individuo sarà disincarnato in tutto o in parte? Tutti godranno del prolungamento esponenziale della vita o solo una minoranza? Differenti durate della vita diventeranno conclamate discriminanti di classe? Domande da film di fantascienza. Domande legittime se un giorno dalla vita si uscirà vivi.
Output.
Negare il potere dei media è come negare la luce del sole. Eppure è quello che avviene da circa trentanni a questa parte nelle facoltà di scienze della comunicazione. Ma se i media non influenzano il comportamento collettivo cosa resta? Resta la borghese libertà del soggetto. Per il quale le istituzioni mediatiche esistano per favorirne il movimento: si può passare da un canale televisivo allaltro, si può scegliere questa o quella app, questo o quel social network, questa o quella piattaforma. Dalla libertà formale al potere sostanziale il passo è stato breve. Anno dopo anno i manuali più diffusi di sociologia della comunicazione hanno finito per trasferire il potere dei media dai produttori di contenuti ai consumatori. Dunque, si insegna agli studenti a non criticare la cultura di massa (perché non esiste più dato che l’audience è frammentata), a non indagare la pubblicità (perché è un linguaggio tra gli altri), all’inerzia nei confronti del sistema dell’informazione (perché non influenza i destinatari). Obiettivi raggiunti, almeno nel mondo dell’accademia. Dove da decenni non si protesta più e dove fioriscono cavillosi studi (prevalentemente provenienti dall’area culturale anglosassone e ruminati in Italia) che si soffermano su aspetti particolari nel comportamento dello spettatore e li assumono come esemplari. Per esempio, la scoperta che frange di pubblico intrepretino più o meno a loro uso e consumo determinati contenuti trasmessi dai tradizionali mezzi di comunicazione serve a confermare, da un lato, lidea di un destinatario partecipante, attivo, messo alla pari con l’emittente e, dall’altro, la bontà della formula determinista secondo la quale il medium è il messaggio. Perciò la critica ai contenuti è inutile per non dire sbagliata. Di conseguenza la ricerca e la riflessione sono sempre meno orientate a verificare le abissali disuguaglianze tra chi genera i prodotti mediali e chi ne fruisce o a esplorare quanto i valori promossi dai media vecchi e nuovi appartengano all’ideologia neoliberale. La sociologia accademica fa bene il suo lavoro e contribuisce alla produzione delle idee dominanti. Il risultato sono nuove alienazioni.
Dott. Patrizio Paolinelli, La Critica Sociologica, LVIII 229, Primavera 2024